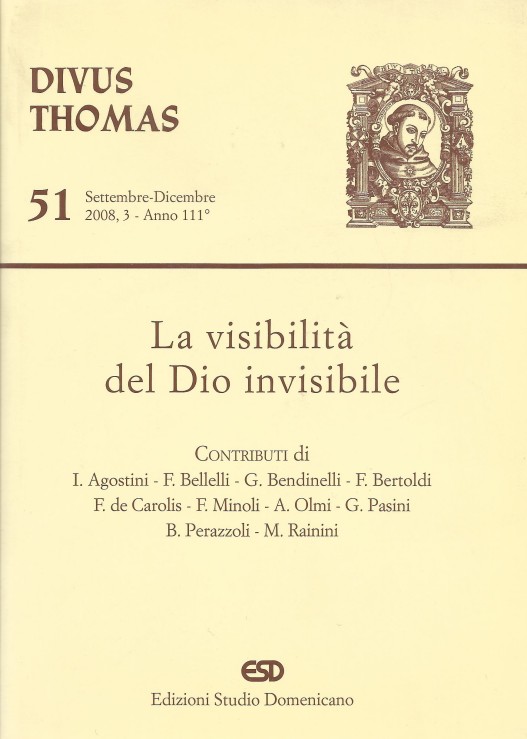
Verità e certezza:
il ruolo dei fattori extrateoretici
Pub. su Divus Thomas, 51, 207-39, 2008
Francesco Bertoldi
Abbiamo parlato in precedenti articoli[1] della necessità che abbiamo di conoscere la verità. Ora entriamo nel cuore del problema della verità, nella specifica prospettiva suggeritaci dal dibattito tra Blondel e il tomismo novecentesco[2].
Abbiamo detto dei motivi per cui crediamo che non sia senza qualche ragione che la filosofia moderna abbia messo in discussione il tradizionale concetto di verità: soprattutto presso la Scolastica, da noi focalizzata con più attenzione, ma almeno un po’ anche nella filosofia medioevale precedente e più ancora nella filosofia classica, si era pensato alla verità in termini per così dire ottimistici, dove l’ottimismo consisteva non tanto nella tesi della possibilità di conoscere il vero, quanto nel modo con cui si riteneva di poterlo attingere.
Vogliamo qui proporre una distinzione che permetta tanto una sostanziale fedeltà al realismo tomista, con la sua chiara affermazione della attingibilità del vero, quanto una valorizzazione delle perplessità moderne circa la verità, perplessità che in effetti colgono una dimensione reale del fenomeno conoscitivo, pur dandone una interpretazione inaccettabile. Molti degli errori che hanno generato le dicotomie apparentemente insanabili a proposito della verità, in cui si è lacerato tanto il pensiero antimetafisico quanto quello metafisico postmedioevale nascono, a nostro parere, dal non aver distinto questi due livelli. La distinzione è tra due dimensioni del vero, ossia la attingibilità e la possedibilità: la verità, anteriormente a un coinvolgimento integrale del soggetto, è sì attingibile (come ha giustamente sostenuto il realismo classico), ma non soddisfacentemente possedibile (e questo è il fattore che, trascurato dal realismo classico, ha dato lo spunto alla parabola antirealista della filosofia postmedioevale); il che implica che il livello di certezza che si impone automaticamente all’uomo è di tipo freddo, non saziante, mentre solo il libero coinvolgimento integrale del soggetto in una dinamica esperienziale intersoggettiva può farci giungere al livello delle certezze calde, che sono le uniche a risultare in qualche modo sazianti e a dare, per così dire, la “sensazione”, pacificante, di essere nella verità.
La mente umana è fatta per la verità, e conoscerla le è non solo possibile, ma in qualche modo inevitabile; tuttavia il dinamismo concreto che ci può portare a un livello, diciamo così, esistenzialmente soddisfacente di verità, è un dinamismo drammatico, nel senso di non-automatico, né irreversibile.
Se un torto ha avuto il tomismo è stato di non considerare abbastanza la dinamica conoscitiva concreta, che è drammatica, perché non si può fermare al livello di certezza fredda, che si dà inevitabilmente, ma urge al compimento della conoscenza nel conseguimento di certezze calde, non altrimenti attingibili che nel coinvolgimento (drammatico, appunto) della libertà.
1. l'inevitabile attingibilità del vero
Vi è un primo dato da considerare, parlando della verità, ed è l'esistenza di uno sfondo di evidenze immediate, incancellabili e ineludibili, come il fatto di esistere, o il fatto che esista un mondo, strutturato da leggi oggettive, tra cui principalmente il principio di non contraddizione e le altre leggi supreme dell’essere. Circondata da ogni parte dall'essere, la conoscenza non può voltare la faccia da nessuna parte senza imbattersi in esso, che del resto la imbeve fin nelle sue più intime fibre.
La tradizione filosofica occidentale abbonda di argomentazioni a nostro avviso lucide e convincenti in tal senso, dalle prove antisofistiche di Platone e di Aristotele agli argomenti antiscettici di S.Agostino e a S.Tommaso, per arrivare fino alle argomentazioni antikantiane di Hegel, così che non ci sembra il caso di insistere a lungo su questo punto. Riteniamo in proposito particolarmente convincenti, nell'ambito della più recente riflessione filosofica, le molte analisi svolte dal pensiero neoscolastico, da Maritain alla “scuola milanese” (in primis Bontadini e Vanni Rovighi) alle tesi di Seifert[3]. Un imponente numero di filosofi in effetti, lungo tutto il corso della storia del pensiero, ha opposto alle tesi di quanti negavano la possibilità, per la ragione umana, di attingere il vero, un argomento che, pur variando forma, è identico nella sua architettura logica, l'argomento della impossibile coerenza dell'antirealismo[4]. Ci limitiamo pertanto qui ad abbozzare, con stenografica allusività, qualche considerazione.
Il positivo in effetti ci sovrabbonda da ogni lato: come a livello ontologico il nulla non prevale né può prevalere sull'essere, ma è un concetto-limite che ha senso solo in rapporto all'essere, così a livello gnoseologico l'errore e il dubbio non prevalgono né possono prevalere sul vero, ma hanno senso solo come limitazioni di quello. Come non si può definire l'essere come un non-nulla, mentre è semmai il nulla ad essere definibile, in quanto rapportato alla primordiale percezione dell'essere, come un non-essere, poiché non si dà mai il nulla, ma sempre e solo l'essere, nelle sue gradazioni (di maggiore o minore perfezione), così non si può definire la verità come una non-falsità, come una assenza di falso, ma si può piuttosto definire il falso come un non-vero. Così è un fatto osservabile che nessuno possa esistenzialmente mettere in dubbio, neanche per un istante, le verità più immediatamente evidenti, quali i principi supremi dell’essere (non contraddizione, identità, terzo escluso), come giustamente osservava Aristotele nel libro Gamma della Metafisica[5].
Tuttavia se esiste una impostazione filosofica negatrice della evidenza veritativa immediata, ossia quella che potremmo chiamare una impostazione antirealistica, è anche perché essa può accampare come argomento (almeno apparente) in suo favore il fatto che, esistenzialmente, non è vero che tutti e sempre obbediscano a una evidenza immediata non-contraddittoria. Per cui si dovrebbe dire che nessuno può vivere facendo totalmente o fondamentalmente (per lo più) come se le evidenze immediate non fossero tali; ma è anche vero che di fatto nessun essere umano (se si eccettua il caso, per la fede cristiana, di Gesù e di Sua Madre) obbedisce totalmente alle evidenze immediate. E in effetti la vita degli esseri umani, come di fatto sono, è intessuta, potremmo dire, di follia[6], di folle ribellione all’evidenza: lo documenta l’esistenza del male, che corrode la stoffa della vita umana, personale e collettiva. Se esiste del male morale, è perché accettiamo per vero del falso: il non-bene è figlio del non-vero, che nasce dalla volontà, assurda[7], di sottrarsi all’evidenza oggettiva. Gli esseri umani, la fede cristiana dice in seguito al peccato originale, vivono cercando di sottrarsi spesso al giogo della oggettività, alla “tirannia” dell’evidenza immediata, e credono di ritagliarsi spazi di libertà come non dipendenza, seguendo di fatto una logica della contraddizione[8].
Ma la ribellione all’oggettività dell’evidenza, è, proprio per la nostra natura, non creatrice ma creata, necessariamente limitata ad alcuni aspetti e momenti, per così dire, minoritari dell’esistenza. Una negazione esistenziale, che fosse totalizzante e persistente, delle evidenze immediate porterebbe infatti alla piena follia o alla morte. Per questo “la fierezza” ribelle dell’uomo, viene piegata “con morso e briglie” [9] dalla oggettività del reale, e in particolare dalla sofferenza e dalla distruzione che segue ogni violenza contro l’evidenza oggettiva.
Resta comunque che lo sfondo evidenziale immediato ci appare sì come indubitabile ma altresì come costituito da quelle che proponiamo di chiamare certezze fredde. Definiamo così il concetto di certezza fredda: fredda è la certezza che hanno le evidenze immediate (da quelle più universali, come l’esistenza della realtà, i principi supremi dell’essere fino alle verità particolari) nella misura in cui esse non siano assimilate dal soggetto, cioè nella misura in cui manchi l’atto della sua libertà, con cui il soggetto accetti e abbracci il fatto che l’essere gli sia dato (donato), e di conseguenza, riconoscendo almeno implicitamente la bontà del reale, segno di un Tu infinitamente buono, viva assumendo e verificando l’invito contenuto nelle evidenze immediate. In altri termini fredda è la certezza delle evidenze immediate nella misura in cui esse siano oggetto di una pura visione (intellettuale) [10], per visione intendendo un atto puramente conoscitivo.
Quali sono le caratteristiche di questo tipo di certezza? Ci sembra si possano tratteggiare due aspetti complementari: da un lato si tratta di una certezza per così dire continuativa, permanente, in quanto non è realmente, in quello che potremmo chiamare il suo nucleo profondo, cioè nel suo essere dato immediato, soggetta a fluttuazioni. Questo vantaggio della continuità è però bilanciato dal limite della sua intrinseca qualità, per cui si potrebbe definire come una certezza “diluita”, o tenue, debole, quindi in qualche modo insufficiente, nel senso di non-saziante; il che porta poi chi volesse fermarsi a questo livello, ad una condizione di fluttuante oscillazione nella percezione complessiva del vero e di instabilità nella adesione ai contenuti di quanto viene ritenuto vero.
Perciò si potrebbe chiamare sfondale (cioè facente da sfondo) questo tipo di certezza: essa costituisce lo sfondo intrascendibile e inesorabile della conoscenza umana[11]; si tratta di uno sfondo non sfuggente o scivoloso, ma solido. Esso tuttavia, per il suo carattere non-saziante, non può non rimandare oltre sé. Come ci proponiamo di mostrare nel prossimo paragrafo.
2. la non-possedibilità del vero
Vediamo di chiarire dunque anzitutto in che senso il tipo di certezza che abbiamo definito fredda sia non-saziante, ovvero non-possedibile[12]. Ci sembra che si possa dire che il paradosso della certezza fredda sia quello di essere conoscitivamente solida, ma affettivamente inappagante. Si tratta cioè di una vera certezza, dal punto di vista conoscitivo, che tuttavia si presenta come affettivamente non appagante. Perché si dà tale non-appagamento affettivo della certezza fredda? Perché nostra natura ci spinge a cercare qualcosa di totalizzante, e non può riposare stabilmente in qualcosa che non lo sia (come ricordava S.Agostino: inquietum est cor nostrum …). Ora, le certezze fredde presentano un dato essenzialmente molteplice e frammentato, la cui unità appare, nella sua immediatezza[13], debole e il cui senso ultimo non pienamente decifrabile. È dunque impossibile per la conoscenza umana appagarsi di tale parzialità.
Quanto stiamo dicendo implica certamente la tesi di una intrinseca connessione tra conoscenza e affettività/desiderio. Noi riteniamo in effetti che non sia possibile scindere il concreto dinamismo della conoscenza (specie di quella relativa al senso ultimo della realtà) da un continuo e strutturale riferimento al desiderio. Non si da mai una “pura” conoscenza. Si conosce desiderando la verità (e la si desidera conoscendola). Questa profonda unità tra la sfera conoscitiva e quella affettiva era chiaramente sostenuta dalla corrente “agostiniana”, ad esempio nella tesi della unità delle potenze dell’anima[14], ma non era estranea allo stesso Tommaso. Ora, se tale nesso esiste, dire (con S.Agostino, ma anche con S.Tommaso: il desiderium naturale videndi Deum) che il desiderio è proiettato verso l’Infinito, non è senza conseguenze sulla stessa conoscenza: una conoscenza concepita come non scissa dal desiderio, non può trovare il suo compimento dove il desiderio non trova compimento. Non può quindi trovare compimento in un livello di evidenze parziali, frammentate, prive in loro stesse di un senso unitario compiuto.
Da questo primo tratto della non-possedibilità, ossia il suo intrinseco carattere di incompiutezza, per cui non-possedibile equivale, nel senso in cui qui lo usiamo, a non-saziante, e quindi intrinsecamente rimandante a un ulteriore, deriva un secondo tratto, ossia il carattere di non-stabilità nel tempo, non tanto delle certezze fredde, ma dell’edificio su di esse costruito, nella misura in cui si precluda il giungere di tali certezze al loro compimento adeguato, costituito dalle certezze calde. È stabile il dato delle certezze fredde, ma non il costruito sulle certezze fredde. Le certezze fredde infatti non sono un fondamento adeguato per un sapere circa il senso ultimo, ma sono, per così dire, un pre-fondamento, il cui unico adeguato sviluppo sono le certezze calde; mentre la pretesa di fare delle certezze fredde un fondamento adeguato al sapere ultimo rende instabile e pericolante l’edificio così costruito. In un ipotetico stato di pura natura, perciò, le certezze fredde sarebbero stabili; nella concreta economia storica, segnata dall’inevitabilità di un progetto totalizzante, le certezze fredde sono instabili.
Se la radice della instabilità è l’incompiutezza, è tuttavia l’instabilità nel possesso del vero il dato fenomenologicamente più imponente e documentabile, come ora appunto cercheremo di mostrare.
1. conferma esistenziale. Ci sembra infatti che chiunque possa verificare in sé stesso, nella misura della sua sincerità e della sua attenzione alla propria situazione effettiva, come la verità (nella misura in cui si arresta al livello di certezza fredda) non sia un possesso stabile; ci sembra ad esempio che chiunque possa verificare quanto sia facile il fenomeno accennato da Leopardi, per cui da “visioni altere”, da un entusiastico senso di pienezza, si possa scadere molto in fretta a spaesata confusione:
“se un discorde accento/fere l’orecchio, in nulla/torna quel paradiso in un momento”[15].
Più in generale ci sembra che chiunque sia attento alla propria esperienza possa constatare come la coscienza di sé e del senso della realtà non sia totalmente stabile[16].
Si tratta di una esperienza che chiunque può osservare in sé, ma al cui riconoscimento è tanto più abilitata una coscienza credente (soprattutto cristiana), in quanto particolarmente sensibilizzata al senso profondo del proprio agire, attraverso e oltre le più immediate motivazioni contingenti, come scelta continua tra il Bene e il Male, in cui ad ogni istante ci si può volgere, mendicandone la Misericordia[17], al Mistero buono, ma in cui anche, ad ogni istante, ci si può invece distogliere da Lui[18]. Per questo chi è credente sa che la dimensione temporale che più conta non è né il passato, né il futuro, ma il presente[19]. Ora questa drammatica decisività del presente dice di una variabilità continuamente possibile. Ma questa variabilità possibile riguarda solo la scelta morale, non solo la volontà (e quindi il valore etico di un essere umano), ma anche la consapevolezza, per ciò almeno che concerne la verità “sintetica”, il tipo di percezione e di certezza relativo al senso ultimo della realtà. Se non è assicurato che ciò che era stato scelto un istante prima, o un giorno prima, o un anno prima, lo sia anche l’istante, il giorno, l’anno dopo, non è nemmeno assicurato che la consapevolezza del senso della realtà si mantenga costante nel tempo. E questo documenta ciò che intendiamo dire, parlando di non-possedibilità della verità.
È da notare che fermarsi alle certezze fredde come dato adeguatamente fondante implica una separazione tra conoscenza e affettività[20]; solo se si recide la seconda dalla prima ci si può appagare delle certezze fredde. Ed è esattamente questo che ha fatto molta filosofia moderna. Questo è evidente ad esempio in Cartesio, ma anche in altri autori filosofici moderni: tali autori hanno preteso di isolare una certezza da cui fosse espunta ogni componente affettiva, per fondare le loro costruzioni solo su tale tipo di certezza. Ai loro occhi tale procedura avrebbe dovuto assicurare una robusta indubitabilità della conoscenza così raggiunta, scevra da ogni fattore extrarazionale. Ma il risultato è stato invece esattamente opposto: già nell’empirismo affiora l’esito disgregatore di una pretesa razionalistica, per giungere con Kant e le filosofie successive al conclamato approdo di una rinuncia alla possibilità di attingere una certezza sulla realtà (sul livello ontologico della realtà).
Alla fine della sua parabola, così, il serpente si è morso la coda, rinnegando, con l’idealismo e Marx, il dato di una pura razionalità fondante.
La non-possedibilità del vero ci sembra dunque possa essere ricondotta al nesso tra conoscenza (soprattutto come conoscenza di verità sintetiche) e affettività, conoscenza e libertà: è impossibile che scegliere in modo diverso non implichi anche, e proporzionalmente, conoscere in modo diverso (e viceversa). Conoscenza e affettività non sono infatti due sfere reciprocamente indipendenti. Ora la nostra libertà di scelta non è in una situazione di facile e tranquilla stabilità. Il fatto è che la posta in gioco nella vita è un valore infinito, il cui attingimento non è assicurato necessariamente, ma è affidato alla nostra continuamente interpellata libertà. La posta in gioco è un valore infinito: se non altro nel senso che non possiamo non desiderarlo, non possiamo non desiderare la felicità e la vita senza fine.
Se la materia fosse il nostro orizzonte ultimo, potremmo dire con Sweeney, in Sweeney Agonist di Eliot: “qui non v’è altro che nascita, copula e morte”[21], ed esserne tranquillamente soddisfatti; ma se la vita è prendere posizione davanti all’Eterno, e la posta in gioco sono l’eterna felicità o l’eterna sofferenza, la vita o il nulla eterni, allora non è sproporzionato avvertirne la drammaticità[22].
Lo abbiamo già detto: ciò che è variabile non è il nucleo profondo delle evidenze immediate, che costituiscono uno sfondo stabilmente indubitabile, come certezze fredde. Questo sfondo, per usare la terminologia impiegata nella polemica del padre Garrigou-Lagrange con Blondel[23], “si impone in noi”.
Il che non toglie tuttavia che si tratti di un sfondo evidenziale che resta “debole”, difetta di una piena e totalizzante forza persuasiva. C’è infatti modo e modo di percepire una medesima verità. Tutti “sanno e non sanno”[24], ad esempio, questa verità, “io morirò”: tutti lo sanno, almeno astrattamente, come certezza fredda, ma quasi tutti, per buona parte del tempo della loro vita, non ne percepiscono fino in fondo la realtà effettiva. Quindi è vero che, in un certo senso, le evidenze immediate non ci sfuggono mai; tuttavia posso affermarle come non affermandole, senza cioè percepirle davvero[25].
Dunque le certezze fredde sono soltanto, per usare un termine caro a Blondel, un trampolino per un ulteriore tipo di certezza. “Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà” (Lc 9, 24), ha detto Gesù, chi cioè vorrà tenere stretto a sé ciò che crede di poter possedere, lo perderà. Così, parafrasando tale ammonimento, si potrebbe dire che chi vorrà abbarbicarsi alle certezze fredde, rifiutando il salto verso quella intensificazione della conoscenza che implica un coinvolgimento integrale di sé, finirà col perdere anche quelle certezze: la parabola, già accennata, della filosofia moderna lo sta a documentare.
3. l'indeducibile sovra-attingibilità del vero
Abbiamo finora visto come si dia un inevitabile sfondo di evidenze e di verità, ma come questo sfondo, finché non entrino in gioco altri fattori, finché cioè resti una dato puramente speculativo, si riveli non saziante.
requisiti e coordinate generiche
Il contesto culturale odierno oscilla tra due posizioni apparentemente antitetiche, ma egualmente distruttive dell'umano, quella scettico-nichilista e quella ideologico-fanatica (fino a qualche tempo fa nella sua variante antiteistica, oggi soprattutto in quella pseudoteistica). Per evitare efficacemente questi estremi occorre da un lato oltrepassare quel livello minimale di certezza, che abbiamo proposto di definire “fredda”, in direzione di un suo compimento, di una sua fioritura in un nuovo livello di certezza, senza che d'altro lato quest’ultima contraddica e neghi quella: oltre non significa contro. Esiste in effetti una certezza che potremmo chiamare “calda”, che non rinnega niente di quanto è innegabilmente certo (di certezza fredda), ma al contrario si presenta come suo tendenziale compimento.
1. Si possono vedere lo scetticismo e il relativismo come esito di un innaturale blocco della dinamica conoscitiva al livello delle certezze fredde. Si tratta di un blocco innaturale perché, come abbiamo detto, l’impeto naturale della conoscenza, inscindibile dal desiderio di pienezza totale, vorrebbe avanzare dal qualcosa al tutto, mentre il relativismo pretende farlo retrocedere dal qualcosa al nulla. Il qualcosa della certezza fredda è anticipo e caparra del tutto della certezza calda[26], non del nulla dello scetticismo. Il fenomeno dell’inquietudine spirituale, che accompagna chi fa professione di relativismo, è sintomatico della innaturalità della pretesa di tale impostazione. Tale inquietudine può benissimo non essere ammessa dal soggetto interessato, ma si palesa comunque, a chi abbia uno sguardo semplice, nel senso di non patologicamente complicato, si palesa ad esempio come innaturale sforzo di azzeramento della dimensione affettivo-emozionale, come compassata impassibilità, oppure come banalizzante superficialità, programmaticamente indifferente al dramma, proprio e altrui.
2. Errore speculare è il pretendere di disporre di una certezza calda che si configuri in discontinuità con il dato primordiale delle certezze fredde, che cioè rifiuti di misurarsi continuamente con il dato originario. Mentre una certezza calda autentica non si costruisce distruggendo ciò che per la certezza fredda era evidente, ma anzi è in continuità con esso, e ne rende pienamente ragione. Quando così non è, si ha uno sviluppo della conoscenza che si nutre non tanto di certezze, quanto di pseudo-certezze: una concezione della realtà di tipo fanatico. Fanatismo è affermare come certo, ciò che tale non si presenta alla conoscenza, almeno in un quel dato momento del suo sviluppo. Il fanatico dice di vedere ciò che non vede. Perciò, tra l’altro, è intrinsecamente inabilitato al dialogo, che può basarsi solo su ciò che è condivisamente visto, su ciò che è oggetto di esperienza intersoggettivamente partecipabile.
Quello che è pienamente rispondente alla dinamica naturale della conoscenza umana è invece uno sviluppo delle evidenze immediate che ne maturi e ne intensifichi la certezza, senza mai stravolgere o negare niente di quanto è primariamente evidente. Nuoce alla verità l’impazienza della totalità, che, selezionando alcuni aspetti delle evidenze immediate, ne nega violentemente altri, e costruisce così, su basi parziali, una pseudo-totalità.
il fenomeno certezza calda
Che cosa intendiamo esattamente per certezza calda? Intendiamo quel tipo di qualità che ha una verità quando, in forza di una sinergia di fattori anche non direttamente conoscitivi (come una intersoggettività vissuta con serietà e come un coinvolgimento globale della adesione affettiva), essa si presenta e viene percepita con una intensità, tale da non poter essere esistenzialmente messa in dubbio e da avere una forza in grado di muovere la vita, di far ragionevolmente rischiare la totalità del soggetto, in una condizione che sia al contempo di abbandono e di padronanza di sé (occorre infatti che non si perda per davvero l’autentico controllo di sé, ma anzi si abbia in sommo grado la ragionevole percezione di un vero possesso di sé) [27].
Ciò che proponiamo di chiamare certezza calda è un fenomeno sperimentabile, oggetto di esperienza esistenziale. Lo diciamo perché ne siamo testimoni, in noi e in altri; riteniamo che questo fenomeno sia verificabile in qualche modo anche in quanti abbiano una adeguata attenzione alla loro esperienza umana; inoltre una lettura non contorta della storia della filosofia, della letteratura, della santità cristiana offre di che ritenere che l’esperienza della “certezza calda” sia qualcosa di ricorrente e di diffuso[28].
È esperienza di ogni uomo che esistano, nella propria vita, momenti e situazioni in cui la propria conoscenza non viene più percepita come statica presa d’atto di oggettività lontane ed estranee su cui freddamente riflettere, ma come coinvolta e dettata dal trascinante darsi di una presenza. Una stessa verità allora può venir percepita in modo qualitativamente diverso, più intenso e vivido[29].
le dimensioni del fenomeno
Possiamo dire che la certezza calda ha due coordinate (che con de Lubac potremmo chiamare paradossali[30]): da un lato l’indeducibilità, il suo non esser esito di una tecnica, configurandosi invece come l’avvenimento di un dono, indeducibile e imprevedibile. D’altro lato essa non procede per così dire in parallelo al “normale” dinamismo argomentativo, non gli è né ostile, né estranea; ma se, accolta, lo permea e lo sostiene, ne è il più corrispondente sviluppo.
La certezza calda, dunque, si presenta come un avvenimento, cioè anzitutto qualcosa che si incontra; e che ha due tratti fondamentali: a) la contingenza, dunque l’imprevedibilità e b) l’oggettiva indiscutibilità (non è tale da esigere una particolari analisi per essere colto; si vede, come uno che mi venga incontro per strada).
In secondo luogo non si tratta semplicemente di un fatto: a differenza di un “fatto”, un "avvenimento" reca in sé una pretesa di importanza, è un “qui ed ora” che ha in sé l’accento inconfondibile di un “per tutti e per sempre”, una sorta di “universale concreto”. Questa importanza che un avvenimento reca in sé deriva dall’essere interessante per il desiderio fondamentale che mi costituisce come essere umano. Incontro tanti fatti, che mi possono lasciare indifferente; un avvenimento è tale se mi riguarda, e se mi riguarda a un livello profondo, decisivo. Per questo, nella fattispecie, l’avvenimento che genera la certezza calda, ha un accento di universalità e definitività, “per tutti e per sempre”, contiene una promessa di totalità.
La certezza calda implica una sorta di evidenza; tuttavia è una evidenza di tipo speciale, in quanto si presenta come una evidenza, per così dire, eludibile. Cerchiamo di esaminare in che senso.
1. La certezza calda è riferita ad una evidenza, per quanto di tipo speciale: essa è infatti relativa ad un dato, che si offre alla conoscenza, un dato cioè contemplabile. Abbiamo detto che è suscitata da qualcosa che si incontra, da un avvenimento. Non può in effetti una certezza risolversi in cause di tipo efficiente, e, nella fattispecie, emozionale o affettiva (per cui sarei certo per il fatto che sento, emozionalmente, che è così, perché sono felice, o entusiasta); occorre la presenza di quella che ancora con linguaggio scolastico possiamo chiamare una causalità formale, il darsi di una forma contemplabile, l’offrirsi allo sguardo[31] del soggetto di un ob-jectum, di un conoscibile, gettato-avanti, posto-davanti al soggetto. Solo così si può parlare di una vera certezza. È fondamentale riconoscere questo carattere propriamente conoscitivo della certezza calda, senza il quale in effetti la sua dignità teoretica sarebbe imparagonabile a quella della certezza fredda.
2. L’eludibilità della certezza calda non significa, ovviamente, che essa non sia certezza, ma che l’ob-jectum a cui si rapporta, pur essendo oggettivamente dato e presente, richiede per essere riconosciuto una sinergia di fattori soggettivi (affettivi oltre che conoscitivi, o meglio di un livello conoscitivo in cui è implicata l’affettività) rettamente dispiegati secondo la loro natura, richiede infatti, in sintesi, di essere guardato, e guardato con simpatia, fattori ambedue non necessari. In effetti la radice della eludibilità dell’evidenza tipica della certezza calda è il suo essere l’evidenza di un singolare (pur implicante una apertura alla totalità), in quanto tale in qualche modo imparagonabile. Il singolare a cui si relaziona la certezza calda non può in effetti essere considerato come esemplificativo di una universalità; tuttavia esiste una sorta di paragonabilità: non a una universalità oggettiva, ma alla attesa di densità che anima il desiderio.
La certezza calda insomma ha il suo punto di (apparente) debolezza esattamente dove ha il suo punto di forza: nel suo essere riferita a un avvenimento concreto, indiscutibile nella sua singolarità, ma la cui portata totalizzante può essere elusa, proprio estrapolandone la dimensione di singolarità, come (presuntamente) alternativa alla pretesa di universalità-permanenza.
I fattori del fenomeno
Volendo ora analizzare ulteriormente il fenomeno della certezza calda, ci sembra che il suo ob-jectum si presenti fenomenologicamente con i seguenti fattori:
-
Anzitutto vi è, come già abbiamo detto, il carattere singolare concreto della realtà a cui si riferisce la certezza calda: non si tratta di essenze o leggi universali, ma di fatti, situazioni, persone singolari.
-
Questo singolare concreto si configura soprattutto come una realtà personale, umana. La realtà infraumana viene a costituire una componente della certezza calda, solo grazie al rapporto personale, alla relazione con dei “tu”. Vi è dunque una necessaria componente di intersoggettività perché possa darsi una certezza calda.
-
Ma un rapporto intersoggettivo non dà luogo a vera certezza senza coinvolgere la libertà del soggetto: vi è dunque una necessaria componente di azione, per usare un termine blondeliano, di impegno della libera volontà nella situazionalità concreta, che consenta di raggiungere la piena integrità del vissuto, a cui si riferisce la certezza calda.
Passiamo ora ad analizzare questi tre fattori del fenomeno certezza calda.
1. dignità filosofica del singolare-concreto
Quella che abbiamo proposto di definire certezza calda ha come condizione il riferimento a un che di singolare concreto, come abbiamo detto. Chiariamo che per singolare concreto non intendiamo un generico dato sensibile, e tanto meno un dato sensibile empiristicamente inteso. Non si tratta, come pensa l’empirismo classico, di una frammentata congerie di atomi conoscitivi, ma di una totalità unitaria, in cui in primo piano (non necessariamente perché attualmente presenti) stanno presenze personali, dei tu, con i quali l’io imbastisce una trama di rapporti, affettivamente contrassegnati, che configurano una storia, in cui non si dà indefinita ripetibilità ma irreversibile cammino di eventi unici.
A differenza di quanto pensa l’empirismo, non è importante il singolare in quanto tale, ma in quanto portatore di universalità, di senso (di un senso metempirico), e perciò ad essere importante non sono genericamente tutti i singolari, ma alcuni; ad essere importante, anzi decisiva, è una specifica porzione della realtà singolare, dentro cui affiora il senso totale. Ci sono persone e eventi (singolari) che veicolano in sé un valore universale, e in qualche modo infinito: suprema saggezza della ragione è non obiettare contro la possibilità di tale eventualità, ma piegarvisi umilmente, nel caso in cui lì intraveda la possibilità di rispondere al suo più grande bisogno, che è la conoscenza della verità ultima.
Si potrebbe dunque dire che una filosofia che riconoscesse la dignità del singolare concreto dovrebbe poter dire: “ciò che io ho «visto e udito» e avrei anche potuto non vedere, è a pieno titolo fattore di costruzione filosofica”. Si dovrà peraltro convenire che una simile attitudine è pressoché assente dalla scena della produzione filosofica, in quasi tutto l’arco della sua storia.
La dignità dell’evento singolare solo teologicamente ha trovato, nell’ultimo secolo e mezzo, una importante valorizzazione in pensatori come R.Guardini, Teilhard de Chardin, e soprattutto von Balthasar[32]. L’eccezione filosoficamente più significativa ci sembra quella di S.Agostino, che, specie nelle Confessioni, fa della sua esperienza, dei suoi incontri, dei fatti della sua vita, materiale filosofico a pieno titolo[33].
I motivi che si possono cercare per rendere ragione di questa esclusione sono riconducibili a una comune radice, che potremmo chiamare di orgoglio. Riconoscere la decisività del singolare-concreto è infatti riconoscere che la qualità adeguata della verità poggia su qualcosa che non è nelle nostre mani, non è esito programmabile e prevedibile di una tecnica conoscitiva, ma è in qualche modo dono imprevedibile. E accettare questo implica ammettere la propria non-autosufficienza, il proprio debito verso altro, e ultimamente verso un Altro.
2. certezza calda e intersoggettività
“La verità è opera di uomini che vivono insieme e discutono con benevolenza” (Platone)
Il singolare concreto dentro cui è veicolato il correlativo della certezza calda non è essenzialmente l’infraumano, ma l’umano[34]. Nel Novecento il tema dell’intersoggettività ha acquisito piena dignità filosofica, grazie all’apporto di filosofi come Martin Buber[35], benché anche in momenti precedenti della storia della filosofia non mancassero tracce di questo tema[36].
L’avvenimento di un rapporto intersoggettivo autentico non solo ha a che fare con verità, ma in un certo senso essa è condizione della verità, o meglio è una condizione del darsi effettivo, esistenziale, della verità con quella qualità che abbiamo chiamato certezza calda.
La fede cristiana lo afferma in modo esplicito: fides ex auditu, senza una comunicazione di testimoni la Verità rivelata da Dio non sarebbe giunta a noi. La fede implica rapporto intersoggettivo. Ma questo non vale solo per la verità rivelata. Vi è una valenza propriamente gnoseologica del rapporto intersoggettivo anche per la stessa verità filosofica, razionalmente attingibile. Il rapporto con gli altri influenza il mio attingere la verità, sia per ciò che concerne i contenuti della verità, sia anche, e forse ancor più, per quello che si potrebbe chiamare il clima mentale, o la qualità contestuale del vero.
a. Per quanto concerne i contenuti della verità filosofica l’apporto degli altri è insostituibile, a partire dall’apparentemente banale debito del linguaggio e del sapere: che cosa davvero conosciamo che non abbiamo ricevuto dal rapporto, prima con i nostri genitori, poi con educatori, amici, libri, istituzioni scolastiche o informative, insomma dal rapporto con altri? È vero che con le perle di una vera conoscenza ci è giunta anche la molta fanghiglia di equivoci, errori, approssimazioni o anche di distorsioni della verità, ma dobbiamo ammettere da un lato che la natura ci ha fornito anche un criterio con cui discernere la perla dal fango, e d’altro lato che soli, su un’isola deserta, non avremmo potuto conoscere che deboli brandelli di verità. Come notava Maritain, Cartesio, che pur pretendeva di “depromere ex thesauro mentis” tutta la verità di cui aveva bisogno, è molto più dipendente di quanto immaginasse dalla sua balia.
b. Ma non sono solo i contenuti della verità ad essere in gran parte debito del rapporto con gli altri, lo è anche l’involucro affettivo, per così dire, il modo, la forma, la qualità certitudinale del vero. Nel senso che lo stesso contenuto di verità (la stessa sostanza, per usare un termine aristotelico) cambia qualità (cambia livello di certezza) a secondo che sia o no oggetto di comunicazione intersoggettiva, e in base alla autenticità/profondità di essa. Posso infatti compiere delle riflessioni corrette su una certa cosa, su un problema che ho o una persona che conosco, ma è diversa la qualità, per così dire, certitudinale della mia conoscenza se di quella cosa parlo con un altro, e la qualità è tanto migliore quanto più il rapporto è serio, e serio è l’altro, con cui comunico. Nell’ambito della verità sapienziale, che è quello che qui ci interessa, posso anche, ad esempio, argomentare razionalmente in modo corretto sull’esistenza di Dio, ma una certezza esistenziale forte al riguardo non può eludere l’evento di un rapporto intersoggettivo con chi mi testimonia, nella sua stessa realtà umana, tale verità. E quest’ultima cosa non è una aggiunta insignificante, perché una verità (sapienziale) che non sia esistenzialmente certa, non ha raggiunto la sua piena statura teoretica.
L’intersoggettività viene per lo più intesa in un senso che si potrebbe dire generico, o meglio indifferenziato. Ci sembra tuttavia che ad essere condizione di pieno accesso alla verità e alla sua qualità certitudinale non sia indifferentemente qualsiasi rapporto intersoggettivo, ma solo un rapporto intersoggettivo che si configuri come autentico. Un rapporto intersoggettivo è tanto più costitutivo di certezza calda quanto più i soggetti che si rapportano sono veri. Viceversa un rapporto intersoggettivo può diventa fattore ostruente nei confronti della verità, nella misura in cui i soggetti che si rapportano non sono veri.
Occorre forse chiarire il senso delle espressioni “vero” e “verità di sé”. Intendiamo per vero un soggetto umano nella misura in cui attua la verità di sé, cioè la sua natura. L'uomo, a differenza di piante e animali, è intelligente e libero, ed è chiamato a ad attuare consapevolmente ciò che piante e animali attuano inconsapevolmente, cioè la propria natura. Una pianta o un animale, in questo senso, sono necessariamente veri, l'uomo no. Riconoscere e attuare la propria natura per un essere intelligente significa essenzialmente aderire alla verità che gli è data come gli è data, non sottrarsi all’evidenza e alle sue implicazioni.
Un soggetto umano è vero dunque nella misura in cui riconosce e aderisce alla verità. Ma a sua volta il suo esser-vero lo abilita a conoscere sempre più adeguatamente la oggettività del vero. In qualche modo cioè si dà una circolarità tra la verità (oggettiva) e l’esser-vero del soggetto conoscente, per cui il vero oggettivo (relativo alla totalità di senso) è proporzionale alla verità del soggetto, e a sua volta quest’ultima si costituisce aderendo alla oggettività del vero. Così la verità impersonale scaturisce, almeno in parte, dalla verità personale, e su di essa ridonda.
Come deve essere inteso allora l’apporto dell’intersoggettività nell’attingimento delle certezze calde? Nel senso che l’esser-vero di un soggetto è facilitato e sostenuto dall’esser-vero di altri soggetti con cui egli ha un rapporto autentico.
1. Come viene ad attuarsi questa verità di sé? Come diceva la metafisica aristotelico-tomista, ciò che è in potenza non passa all’atto, se non in virtù di ciò che è già in atto (quod non est non incipit esse nisi per aliquid quod est). Nella fattispecie è una soggettività più vera della mia che mi aiuta ad essere vero[37]. Ma ciò è tanto più vero nella concreta economia delle cose, segnata, come abbiamo già accennato, dal peccato originale e dalla redenzione: è fondamentale l’incontro con umanità più vere. Non posso cambiare la mia umanità autocentrica ed egoista, legata alla menzogna, senza un aiuto esterno. In primo luogo dunque c'è l’altro, un altro più vero. Ci sia consentito richiamare a questo proposito un passaggio di una poesia di S.Giovanni della Croce:
Cuando tu me mirabas, / su gracia en mí tus ojos imprimían: / por eso me adamabas,
y en eso merecían / los míos adorar lo que en ti vían.
No quieras despreciarme, / que si color moreno en mí allaste / ya bien puedes mirarme
despues que me miraste / que gracia y hermosura en mí dejaste.[38]
Che cosa rende buono, buono anche a vedersi (tanto da essere amabile: “por eso me adamabas”) un soggetto, che di per sé sarebbe incapace di essere vero, sarebbe di “color moreno”, segnato dal male e dalla fragilità? È lo sguardo di un altro (nella poesia di Giovanni della Croce lo stesso Verbo di Dio, ma analogicamente ogni soggetto umano nella misura in cui sia vero): “cuando tu me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían”, lo sguardo dell’altro restituisce una “grazia” a chi è guardato. Poiché quanto più una persona è vera, tanto più riconosce nell’altro, oltre la scorza più immediata dell’apparenza, una verità più profonda, un diamante prezioso, quella dignità infinita che commuove il padre del figliol prodigo[39]. E questo sguardo che sa andare oltre l’apparenza fa cambiare il soggetto che abbraccia (non solo ne coglie la verità, ma in qualche modo la attua, aiutandola ad emergere): il guardare al centro buono dell’altro, offuscato dal “color moreno” del limite brutto e abbruttente, ha reso buona anche tale apparenza esteriore (“gracia y hermosura en mí dejaste”), perché ha a iniziato a far (ri)scoprire la interiore dignità.
2. In secondo luogo la dinamica che abbiamo richiamato può essere, più in profondità, vista in termini di epifanicità. Il darsi di un rapporto vero è segnato dall’esperienza della corporeità non come velante maschera, ma segno, luogo di irradiazione di una profondità interiore. La corporeità può in effetti essere, in un rapporto inautentico, velame, maschera, oggetto[40]: un soggetto, non essendo (puramente e semplicemente), ma in qualche modo avendo il suo corpo, potendone perciò disporre, essendo cioè in rapporto dialettico e non ingenuo e immediato con la propria corporeità, può decidere di usare la corporeità, tramite indispensabile per l’incontro e la comunicazione con gli altri soggetti, rendendola oggetto. In tal modo il corpo diviene oggetto anzitutto del soggetto stesso cui inerisce, che cerca di padroneggiarlo, al di là dei confini di una dinamica naturale, secondo una logica di potere; ma diviene inevitabilmente e per ciò stesso oggetto anche per gli altri soggetti, che saranno facilmente indotti a considerare quel soggetto come oggettività manipolabile[41].
L’affiorare, il trasparire di una forma spirituale nella corporeità coincide con quella che abbiamo chiamato verità di sé: un soggetto umano è vero quando si manifesta come tale, quando la sua corporeità manifesta il suo spirito, allorché accetta e manifesta tale suo esser-così, quando in particolare non si finge pura corporeità, ritirando, per così dire, la propria spiritualità dalla corporeità, rendendola, come dicevamo prima, un puro oggetto, ma assume il rischio e la responsabilità di inabitare pienamente la propria corporeità, permeandola della propria presenza di soggetto ed essendo così in grado di incontrare davvero gli altri[42].
Ma perché l’automanifestazione di un soggetto induce un altro soggetto all’automanifestazione? Se cioè ciò che l’altro mi rivela nella sua epifanicità pratico-corporea non fosse altro che sé stesso, visto come un atomo chiuso, ciò non mi provocherebbe ad automanifestarmi fino in fondo: un cieco non può guidare un altro cieco. Quanto più uno è murato nella sua autoaffermazione esclusiva, tanto meno può provocare all’unità.
Solo se un soggetto rivela, in sé stesso, più di sé stesso, solo se rivela qualcosa che interessa e tocca anche me, può instaurarsi un rapporto di progressiva, reciproca automanifestazione, che porti a un consolidamento della verità di sé. Una manifestazione dell’altro che io non potessi in alcun modo riferire a me stesso, non mi potrebbe interessare, più di quanto almeno non mi interesserebbe l’ipotetica automanifestazione di un pavone. Occorre che nell’altro io possa in qualche modo trovare qualcosa della verità di me. Occorre che si renda in qualche modo percepibile un Fattore che sia presente anche al fondo di me, come qualcosa che costituisce il mio più intimo centro, il cui emergere non posso non desiderare come la condizione indispensabile per la mia piena autocoscienza e realizzazione.
3. la verifica nell’azione
L’ultimo fattore per il coglimento della verità con la qualità di certezza calda è l’impegno della libertà, ossia la verifica, che è sempre in quella che con Blondel possiamo chiamare azione. La verità relativa al senso ultimo non può essere solo contemplata, ma sollecita la nostra azione. Non sarebbe pienamente umana una verità relativa al senso ultimo che si fermasse a una mera contemplazione.
Ciò è dovuto al fatto che il termine, a cui essa rimanda, è, se non altro come ipotesi di lavoro, un Tu. Non ci si può rapportare a un Tu come uno scienziato si può rapportare a dei microrganismi in un vetrino da laboratorio. Ciò è già vero se questo tu è un tu umano, ma lo è ancora di più se si tratta del Tu divino. Già una intersoggettività autentica infatti, essendo una dinamica relazionale tra tu umani, implica una componente di azione, nel senso di coinvolgimento operativo della libertà del soggetto. Rapportarsi in modo autentico, e fruttuoso di certezza “calda”, ad altri soggetti, non può essere qualcosa di automatico, ma richiede l’accettazione libera del soggetto. Riconoscere ad esempio che un altro è più vero di me, ed ha su di me un punto di vista più vero del mio è drammatico, nel preciso senso che implica un atto della libertà[43]. Ancora, occorre il mio coinvolgimento personale, attivo, perché la verità emerga nei rapporti intersoggettivi e perché la verità lì emersa non sia poi dissipata e dimenticata, ma possa fiorire anche in circostanze meno favorevoli. Occorre l’impegno della libertà nell’azione per non essere “uno, nessuno, centomila”, per resistere, facendo appello alla verità sintetica, alle convenienze bio-psicologiche che possono indurci a mascherare la verità di noi stessi.
Ma, se una componente di azione è postulata già nel rapporto tra tu umani, a maggior ragione essa è richiesta in riferimento a questo Tu. Ora, è evidente che la verità relativa al senso ultimo è riferita a un Tu, poiché si tratta in ultima analisi di sapere se la perfezione infinita, che non può che essere un Tu, essendo la personalità una perfezione, esista o no, e quale volto abbia. Per ammettere che occorre una componente di azione nell’attingimento di una qualità certitudinale della verità relativa al senso ultimo, non occorre del resto presupporre che il Tu divino esista, basta anche solo ammetterne la possibilità.
In questo caso infatti si potrebbe, in buona logica, argomentare così: se questo Tu esistesse, sarebbe realizzato il mio più profondo bisogno; ma nessun argomento mi può condurre ad escludere che questo Tu esista, e anzi molti indizi convergono, anche anteriormente al coinvolgimento dell’azione, a documentare come decisamente probabile la Sua esistenza[44]; ora, per sapere con certezza calda se esiste, non ho che una strada: rapportarmi a questo Tu come la Sua natura richiede; se è un Tu, come tale lo devo trattare; e un Tu, a differenza di un “ciò”, lo tratto conformemente alla Sua natura se mi muovo per rapportarmi a Lui, cercando di corrispondere, il meno inadeguatamente possibile, alla Sua presenza. Così, non sarebbe ragionevole e umano il mio comportamento, se venendo a casa mia una personalità importantissima, da cui dipendono delle questioni che mi stanno molto a cuore, non mi muovessi per accoglierla nel miglior modo possibile e corrispondere il più adeguatamente possibile alla realtà del suo status. È vero, non è detto che, trattandola come la sua condizione richiede, io ottenga ciò che voglio; ma è certo che se non la trattassi nel modo migliore non otterrei ciò che voglio. Nel primo caso avrei almeno la possibilità di un sì, nel secondo la certezza di un no. A maggior ragione ciò vale per il Mistero: si può anche pensare che rapportandosi a Lui come un Tu esistente, non si giunga alla certezza della Sua esistenza, ma è certo che rapportandosi a Lui come a un oggetto, non si raggiungerà mai alcuna certezza riguardo ad essa.
C’è un primum che precede la scelta della libertà: è, come abbiamo detto, l’avvenimento oggettivo, gratuito, del darsi, nello spazio "sfondale" e "diluito" delle certezze fredde, di epifanie concreto-umane della verità totale, di esperienze di maggior verità nei rapporti. Ma tale darsi "oggettivo” non darebbe luogo a una certezza calda, come accennavamo, senza che la libertà lavori per corrispondervi. La contemplazione di una concretezza singolare epifanica di un senso totale, senza l’impegno dell’azione, cioè senza il coinvolgimento operativo della libertà del soggetto, resterebbe nella migliore delle ipotesi una sognante estraniazione dal reale, una fuga estetizzante.
Mettiamo allora qui a tema questo fattore, avendo come riferimento soprattutto Maurice Blondel, autore che ha contribuito a sottolineare il valore della verifica libera come condizione perché si possa giungere a una certezza saziante, offrendo un contributo molto positivo circa la dinamica del desiderio e del pieno compimento della certezza.
Anzitutto però precisiamo come intendiamo qui il concetto stesso di azione. Come una contemplazione pura, nel senso di priva di azione, della verità sapienziale, sarebbe incompleta, così specularmente, anzi molto di più, l’azione non può considerarsi autosufficiente; non è l’azione il punto di partenza: ogni azione è, per usare una terminologia scolastica, non solo atto dell’uomo, ma atto umano, che dunque passa necessariamente attraverso la consapevolezza, che è consapevolezza di un dato (contemplato). L’azione è mossa dalla contemplazione[45].
L’azione, come la intendiamo qui, è la risposta affettivo-operativa di un soggetto umano a un dato contemplato di tipo essenzialmente personale. Essa è perciò lavoro per corrispondere (adeguatamente) a un dato, che abbiamo definito personale, nel senso che tale dato è non è semplicemente dato, ma è l’atto di un darsi, del darsi libero di un tu. Come dicevamo è soprattutto il darsi libero-personale del dato a suscitare, come unica adeguata risposta, una altrettanto libera mossa di corrispondenza affettivo-attiva.
Come deve essere inteso il valore probatorio della verifica nell'azione? Si tratta evidentemente di una verifica diversa da quella scientifica, pur avendo un valore probatorio adeguato nel suo ordine. La differenza è data dalla stessa natura di ciò che deve essere verificato: in ambito scientifico si verificano asserzioni concernenti un ciò impersonale, usando un metodo che non mette in gioco la libertà del soggetto verificante, il suo intimo atteggiamento di fronte alla realtà. Lo scienziato moralmente peggiore infatti può giungere a conclusioni vere, se applica correttamente le regole del metodo. Nel caso delle verità sintetiche, oggetto possibile di certezza calda, è invece essenzialmente e direttamente in gioco il rapporto con un tu, con dei tu umani, segno di un Tu infinito, e questo, come abbiamo già accennato poco sopra, non può che chiamare in causa la libertà del soggetto che verifica.
Una teoria scientifica, in generale, è verificata, se la sua applicazione ha successo, cioè se è in grado di prevedere con esattezza fenomeni o di produrne con efficacia, conformemente alle aspettative. Nel caso della verità sapienziale la parola verifica deve ovviamente essere calibrata in un senso meno meccanico. Resta tuttavia che anche qui si tratta di una operatività, tale da assicurare in qualche modo un risultato che si configuri come la conferma della validità dell’ipotesi di lavoro.
L’ipotesi di lavoro in questo caso è offerta da quel primum che è il darsi oggettivo di una presenza umana in cui riluce con più forza l’accento della verità totale, la cui verità uno è chiamato a verificare nella propria esperienza, per vedere se anche in lui quello stesso fattore è attuativo di un compimento. In concreto tale verifica significa fondamentalmente prendere sul serio delle parole, che esprimono e descrivono il dato di quella maggiore autenticità umana.
La maggiore pienezza umana, che risulta dal …verificare il vero, è conferma appunto della verità di ciò che si sta verificando. Questa pienezza umana, per quanto imperfetta e reversibile, ha la forza di una reale dimostrazione della verità. Essa non comprende solo dei tratti affettivi (pace, letizia), quasi si producessero delle emozioni in modo irragionevole, tali tratti sono legati anche a una sperimentata nuova possibilità di agire, appunto più umana, implicando ad esempio una capacità di solidarietà e di perdono, e in generale di fuoriuscita dal cerchio soffocante della propria autocentricità. Fare il vero rende più umani, dunque più realizzati, più felici. E la felicità è garanzia del vero verificato.
Trattandosi di una verifica, in cui è a tema un Tu, potrebbe darsi una obiezione: o questo Tu lo tratto da tu, non oggettivizzandolo in nessun modo, e allora si tratterebbe di una procedura razionalmente illegittima, volta a garantirsi un risultato fissato a priori, infalsificabile; oppure, per verificarlo, lo oggettivizzo, ma allora vengo meno allo statuto epistemologico fondamentale di questo rapporto.
A questa obiezione crediamo si possa rispondere che pur essendo di diritto legittima, è di fatto superata dalla stessa natura effettiva dell’automanifestazione del Tu, che non disdegna di rendersi in qualche modo oggettivabile, nella esperienza umana. La parola verifica, nel senso qui usato, ha pieno valore probatorio perché si rapporta all’oggettività dell’esperienza, che è qualcosa di visibile e di toccabile, di non deducibile a-priori. L'esperienza è quella di una pienezza umana, caratterizzata da pace e letizia. Non esiste un misuratore scientifico di tali fattori affettivi, ma chiunque sia sincero con sé stesso, sa che cosa si intende con tali parole, e sa che non si può confondere pace con angoscia, letizia con noia. È chiaro poi che essendo in gioco un rapporto con dei tu e un Tu sommamente venerabile e misterioso, la verifica dovrà purificarsi da atteggiamenti di pretesa, che fissino dei limiti cronologici o quantitativi, in una sorta di ultimatum. Ma è al contempo vero che la verifica nell’azione è di diritto passibile di esito negativo, la verità che si verifica è falsificabile.
conclusione
Riassumiamo ancora il cammino fin qui proposto: si dà uno sfondo di certezze generiche, le certezze fredde, che costituiscono una evidenza ineliminabile ma non saziante; dentro questo orizzonte generico, la libertà umana è chiamata a riconoscere delle epifanie più specifiche della verità totale, che si caratterizzano per il loro essere umano-interpersonali, e tali da richiedere il coinvolgimento dell’azione. Rapportate ad esse, come abbiamo visto, si danno delle certezze calde.
Il dramma del realismo tradizionale, sopravvissuto soprattutto nelle Scuole ecclesiastiche, in epoca moderna, è stato quello di cercare di convincere la corrente egemone del pensiero moderno, su posizioni sempre più soggettivistiche, che la verità ci fosse e fosse conoscibile perché ci sono le certezze fredde. Ha proposto, come risposta all’ansia moderna, qualcosa di insufficiente, perché non totalizzante.
L’umanità moderna chiedeva, senza saperlo, il calore di un fatto, l’annuncio di un’imprevedibile densità di vita e di conoscenza, mentre i custodi del vero tradizionale si limitavano al, parziale, livello del vero generico-universale, nella sua marmorea e non-affascinante necessità-universalità. Invece di annunciare il loro incontro con la verità come qualcosa di bello e affascinante, come un fatto che sorprendeva anche loro, e che avrebbe potuto (e dovuto) essere sperimentato, hanno insistito unicamente sulla verità come necessaria di diritto, percepita come un orizzonte lontano, poco interessante.
note
[1] “Motivi dell'antirealismo moderno”, Divus Thomas, 32 (anno 105) [2/2002], pp. 175/201, 2002. “Riflessioni sulla necessità e possibilità del vero”,Divus Thomas, 35 (anno 106) [2/2003], pp. 73/85, 2003.
[2] “ Provocazioni sul tema della verità nel tomismo”, Divus Thomas, 10 (anno 98), pp. 9/26, 1995; “La verità in Blondel o la non-possedibilità del vero” [1a], Divus Thomas, 26 (anno 103) [2/2000], pp. 110/132, 2000, [2a], Divus Thomas, 29 (anno 104) [2/2001], pp. 179/202, 2001.
[3] Cfr.Essere e persona, ed Vita e Pensiero, Milano 1989.
[4] Lo scettico che volesse essere coerente dovrebbe, ricordava Aristotele, essere muto come un tronco (omoios phytò). Così, come rimproverava Hegel a Kant, la ragione non può mettere in discussione la sua attitudine generale a cogliere la realtà: sarebbe incoerente infatti che si giudicasse inadatta a giudicare.
[5] Con insuperata pertinenza lo Stagirita osservava che non tutto ciò che uno dice lo pensa anche: vi può essere una dicotomia tra una tesi astrattamente affermata e l’assunzione esistenziale integrale delle sue implicazioni operative. Si può dire che il principio di non contraddizione non sia una certezza, ma non si può vivere facendo come se non lo fosse. Nessuno infatti ad esempio considera equivalente perdere o non perdere dieci milioni, avere o non avere una villa in Costa Smeralda: ma tale equivalenza dovrebbe essere invece affermata se si negasse il principio di non contraddizione, dicendo che essere o non essere, e quindi anche avere e non avere sono la stessa cosa. La vita, con la sua poderosa oggettività impone categoricamente il principio di non contraddizione, e a tale oggettività forza inesorabilmente anche lo scettico più ostinato.
[6] Lo sottolineava, poeticamente, anche Ariosto, immaginando come un po’ del senno di tutti gli uomini sia, come vede Astolfo nel suo viaggio sulla Luna, fuggito dalla Terra (cfr. Orlando furioso, c. XXIV, vv. 82 sgg.).
[7] Perché priva di ragioni, priva di senso: che cosa mancava infatti ad Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre? Eppure danno ascolto all’Estraneo, che li seduce sulla base del nulla, cioè di una non-ragione. Si dirà, come ricordava tra gli altri S.Bonaventura nelle Collationes in Hexaemeron, che il “sillogismo di Satana” non era del tutto falso: “voi dovere diventare come Dio, ma fino ad ora non lo siete, dunque diventatelo”; la premessa maggiore era vera: l'uomo ha in sé il desiderio di trascendere il limite della sua natura, ma la premessa minore cozza contro l’evidenza che il Mistero creatore, fino a qual momento, non aveva fatto loro niente che non fosse per il loro bene, e dunque non era ragionevole dubitare di Lui; per fidarsi, oltretutto di un Estraneo, che non c’entrava nulla con la loro storia.
[8] Esempio tipico nel campo affettivo, allorché una persona legata ad un'altra non vuole escludere un ulteriore legame che di fatto contraddice il primo, come nel caso di un marito infedele, che pur dicendo di amare la moglie non volesse rinunciare all’amante. Ma si potrebbe aggiungere anche l’esempio di rimandare la preghiera: dici di credere che Dio esista e che perciò dovresti pregare, eppure al momento opportuno non preghi, o preghi meno del giusto e male; ossia pensi al contempo una cosa (Dio esiste) e il suo contrario, perché agisci come se non esistesse. Si sprecherebbero, in generale, gli esempi in cui possiamo sorprenderci a dover confessare,se fossimo sinceri, “video meliora proboque, sed deteriora sequor”.
[9] Cfr. Sal. 31, 9: “Non siate come il cavallo e come il mulo privi d'intelligenza; si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no, a te non si avvicinano.”
[10] Evitiamo di usare il termine contemplazione, la quale in realtà implica una integralità di partecipazione delle energie del soggetto, delle sue facoltà, per usare un termine scolastico: si contempla anche col cuore, non escludendo programmaticamente una circolarità tra intelligenza e affettività.
[11] Nella vita presente: in via, non in patria.
[12] È opportuno tenere presente anche quanto abbiamo già detto su questo argomento soprattutto negli articoli su Blondel (“La verità in Blondel o la non-possedibilità del vero” (1° parte), Divus Thomas, 26 (anno 103) [2/2000], pp. 110/132, 2000. “La verità in Blondel o la non-possedibilità del vero” (2° parte), Divus Thomas, 29 (anno 104) [2/2001], pp. 179/202, 2001.
[13] Nel senso che una unità più solida può essere solo l’esito di una mediazione razionale: non è, immediatamente, nel dato, ma solo, mediatamente, nel costruito. L’Essere, nel quale si unifica il molteplice e trova un suo senso adeguato, non è immediatamente evidente (in un certo senso nemmeno per Anselmo e i fautori delle prove a-priori, tant’è che occorre comunque la mediazione di una argomentazione razionale).
[14] Come diceva anche Dante “l’affetto l’intelletto lega” (Paradiso, Canto XIII: “perch’elli ‘ncontra che più volte piega/l’opinion corrente in falsa parte,/e poi l’affetto l’intelletto lega”).
[15] Leopardi, “Sopra il ritratto di una bella donna scolpito nel monumento sepolcrale della medesima”, in Canti (XXXI). Cfr. l’intero passo: “Desiderii infiniti/E visioni altere/Crea nel vago pensiere,/Per natural virtù, dotto concento;/Onde per mar delizioso, arcano/Erra lo spirto umano,/Quasi come a diporto/Ardito notator per l'Oceano:/Ma se un discorde accento/Fere l'orecchio, in nulla/Torna quel paradiso in un momento.”
[16] E nemmeno può essere ritenuta mutevole in modo “linearmente” progressivo, quasi andasse sviluppandosi senza regressioni o senza lotte . È vero, certo, che così può apparire, in molti momenti: per la ragione che risulta psicologicamente difficile ammettere di avere “perso tempo”; ma chi crede sa che lo stesso tempo passato speso male può, nella misura della personale conversione, essere “usato”, nel presente, come molla che spinga con più decisione ad affidarsi a Dio. Come dice una canzone di Cocagnac, “le poids des tes péchés, eux mêmes, te ramènerait, Jérusalem” (lo stesso peso dei tuoi peccati ti ricondurrebbe a Me).
[17] Cfr. 1Gv, 1, 8/10: “Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi.”
[18] Testimonianza di quanto abbiamo cercato di spiegare la si può trovare ad esempio nel linguaggio della Bibbia, in particolare nei Salmi: l’autocoscienza umana che vi si esprime dice di una drammatica possibilità di variazione, da momenti di intensa gioia a momenti di straziante sofferenza, da momenti di luminosa chiarezza a momenti di oscuro disorientamento. Nei Salmi si trovano espressioni di affranta tristezza come: “[2]Salvami, o Dio:/l'acqua mi giunge alla gola. /[3]Affondo nel fango e non ho sostegno; /sono caduto in acque profonde /e l'onda mi travolge.” (Sal 69), ma anche di esultanza come nel Sal 145: “[3]Grande è il Signore e degno di ogni lode, /la sua grandezza non si può misurare. ” Si vedano anche, per quest’ultimo aspetto tutti gli ultimi Salmi (successivi al 145), o altri come il Salmo 80 (Esultate in Dio).
Per questo chi è credente non trova esagerato l’ammonimento di S.Paolo: “chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere” (1Cor, 10, 12), e si riconosce almeno un po’ nella preoccupazione di S.Agostino, “timeo Dominum transeuntem”, o in quella, analoga, di S.Giovanni della Croce: “chi perde l’occasione è come chi lasciò volar via di mano l'uccello che non potrà essere più ripreso” (S.Giovanni della Croce, Avvisi e sentenze, 29, in Opere, Roma, 1975, p.1088).
[19] E per questo capisce che il Nemico, di Dio e dell’uomo, lo tenta continuamente su questo punto, cercando o di proiettarlo verso il futuro, o di ripiegarlo sul passato, facendogli in ogni caso mettere il più possibile tra parentesi il presente. Cfr. C.S.Lewis, Le lettere di Berlicche, tr. it. Mondatori 1979, in cui l’autore immagina un carteggio tra due diavoli, l’esperto Berlicche e il giovane nipote Malacoda. Si veda ad esempio pp. 25/8 e soprattutto pp. 62/4. Tra l’altro: “Noi vogliamo un uomo che sia stregato dal futuro (…) Vogliamo una razza (…) non mai onesta, né gentile, né felice ora, ma che usi continuamente ogni vero dono che le viene offerto nel presente come pura esca da collocare sull’altare del futuro” (Ibi, p. 63).
[20] Fenomeno a cui come abbiamo accennato in un precedente articolo sui motivi dell’antirealismo moderno, “Motivi dell'antirealismo moderno”, Divus Thomas, n. 32 [2/2002], pp. 184/8.
[21] Da Sweeney agonist: “SWEENEY: Nascita, e copula e morte,/Tutto qui, tutto qui, tutto qui,/Nascita, e copula e morte./E se tiri !e somme è tutto qui/Nascita, e copula e morte. /DORIS: Che noia ne avrei! /SWEENEY: Che noi ne avresti! /Nascita, e copula e morte”.
[22] E’ vero che il contenuto della proposta cristiana è quanto di più umanamente equilibrato possa pensarsi: Cristo svela l'uomo all’uomo, facendogli vedere una umanità realizzata, i cui tratti non sono esotericamente bizzarri o superomistici. Cristo non vive come un Super-Uomo, ma come un Uomo: mangia e discorre con i suoi discepoli, e percorre a piedi, impolverandosi e sudando, le strade di quella (esteriormente) banale contrada periferica che era la Palestina di allora. Dunque, in generale, il contenuto di un’esperienza davvero umana non è strano o eccentrico o “superlativo”, ma la tensione morale che lo sostiene deve essere massima, è caratterizzata da una vigilanza che abbracci ogni istante: sappiamo che Gesù usava spesso anche della notte per pregare. La normalità (del contenuto) è pagata a prezzo di una eccezionalità di impegno (nell’atto): solo l’eroismo sostiene la quotidianità (alludiamo allo “slogan” con cui nell’80 si festeggiò il monachesimo benedettino: “era necessario che l’eroico diventasse quotidiano, e il quotidiano diventasse eroico”, cfr. il discorso di Giovanni Paolo II a Norcia, del 23/3/80). Tale è la variabilità possibile nell’animo umano, che senza un impegno eccezionale il contenuto dell’esperienza viene poco o tanto corrompendosi.
[23] Cfr. tra l’altro Garrigou-Lagrange R., "Nécessité de revenir à la definition traditionelle de vérité", Angelicum, 1948, pp.185/98, e "Vérité et immutabilité du dogme", Angelicum, 1947, pp. 124/39, e "La Théologie nouvelle où va-t-elle?", Angelicum, 1946, pp.126/45. Sull’intera vicenda rimandiamo anche al nostro: "Il dibattito sulla verità tra Blondel e Garrigou-Lagrange", in Sapienza, 1990, pp. 293/310.
[24] Lo fa dire Eliot all’arcivescovo Thomas Beckett, nel dramma Assassinio nella cattedrale, rivolto al coro della “povere donne” di canterbury, che preferirebbero rimanere nella loro nicchia di semicoscienza, senza affrontare l’impatto con la realtà, che di lì a poco le avrebbe invece drammaticamente scosse: “Voi sapete e non sapete che cosa sia l’agire e il patire”.
[25] Non si sottolineerà mai abbastanza che non si tratta di un fenomeno semplicemente emozionale e senza rilevanza teoretica; non si tratta di un fattore estrinseco alla dinamica propriamente conoscitiva: non parliamo della percezione di particolari, magari incomunicabili, ma del modo di percepire evidenze (in qualche modo) concettuali (o almeno concettualizzabili) di valore fondamentale, fondativo. Prova ne sia che un intero sistema filosofico può stare o cadere su ciò che primordialmente viene percepito come dato (dato-alla-percezione). È stato osservato che non c’è costruito senza dato, come non c’è edificio senza fondamenta. Come è stato detto, più e prima che su ragionamenti, ogni grande sistema filosofico poggia su una intuizione della realtà, su ciò che viene percepito come primario, fondante.
[26] Si tratta di un “tutto” relativamente al “qualcosa” della certezza fredda, non è ancora la pienezza di conoscenza a cui il nostro animo non può non aspirare; tuttavia di tale pienezza è comunque convincente caparra.
[27] Proponiamo di chiamare "caldo" questo tipo di certezza in quanto essa produce nel soggetto una mobilitazione poco o tanto entusiastica, uno stato d’animo emotivamente caricato, in grado di far affrontare senza insormontabili intoppi l’arco di una azione (/di un complesso di azioni), che un freddamente analitico esame potrebbe sconsigliare dall’intraprendere.
[28] Diffuso non equivale però a universale. Ci sembra opportuno chiederci allora se sia possibile dire che quello della certezza calda sia un fenomeno universale, come lo è quello delle certezze fredde. Crediamo si debba rispondere con questa distinzione: è un fenomeno universalizzabile, anche se di fatto non universale. Tutti ne possono partecipare, ma solo una parte del genere umano fruisce effettivamente di questo compimento della conoscenza. Tutti gli esseri umani, sempre e ovunque, lo vogliano o meno, sono certi, di certezza fredda, delle evidenze immediate. Tutti potrebbero raggiungere, ma solo alcuni di fatto raggiungono una maturazione della conoscenza che li renda certi, di certezza calda, del senso della realtà, e questa maturazione, essendo legata anche al fattore libertà, non è mai raggiunta in modo pieno, definitivo, e irreversibile.
[29] Un esempio di quanto intendiamo dire, sia pur non riferito direttamente al senso ultimo della realtà, è quello di un’esperienza affettiva intensa, in particolare di tipo amoroso; essa appare contrassegnata anche da un potenziamento e da una riorganizzazione della conoscenza. Per usare una espressione di Romano Guardini, si potrebbe dire “nell’esperienza di un grande amore, tutto ciò che accade diventa avvenimento, nel suo ambito” (L'essenza del Cristianesimo, tr.it. Morcelliana, Brescia, 1984, p. 12), cioè le stesse cose non vengono più viste, e conosciute, come prima. Ma in un senso pieno e proprio certezza calda è l’esperienza di una fede, vissuta non come sforzo di coerenza con regole etiche, ma (primariamente) come adesione a un Dato in qualche modo incontrato e affascinante (in un modo che presenta più di una analogia col fenomeno affettivo). L’apice verso cui non può non tendere la conoscenza sapienziale è appunto questo tipo di certezza.
[30] Nel senso dato da de Lubac a questo termine: paradosso come compresenza, misteriosa alla ragione umana, di fattori apparentemente contrastanti. Ad esempio paradosso è il dogma trinitario: il Mistero è al tempo stesso uno e trino; o la compresenza, nel Mistero, di giustizia e misericordia.
[31] Per "sguardo" non intendiamo solo una componente sensoriale, ma una intuizione, una conoscenza immediata, comprensiva del pensiero.
[32] Il teologo svizzero ha in effetti dato ampio spazio, nella sua sintesi teologica, al concetto di bellezza, esattamente nel senso di una realtà concreta particolare che apre alla totalità.
33 Qualcosa di analogo lo si poteva forse già riscontrare in Platone con il personaggio di Socrate; anche se ci sembra si debba dire che Socrate, pur decisivo esistenzialmente nella scelta platonica di dedicarsi alla filosofia, non entri, nelle opere platoniche (fatta eccezione ovviamente, per certi aspetti, per la Apologia), a titolo di persona, ma a titolo di pensatore esemplare; sono le idee del maestro che vengono celebrate e difese, non fatti della sua vita davanti a cui Platone abbia detto “io”. Il Cristianesimo, che permea la filosofia medioevale, avrebbe potuto fornire di che osare in tal senso, ma a quanto ci consta nello stesso cosiddetto agostinismo medioevale non viene riconosciuta al singolare una dignità propriamente filosofica. È vero che nella scuola francescana, da Bonaventura a Scoto, con la sua già citata teoria dell’haecceitas, alla concretezza singolare viene riconosciuta una certa importanza, ma non si può negare che rispetto a S.Agostino, in tali autori vi sia una timidezza molto maggiore nel modo di considerare la valenza filosofica dell’esistenziale concreto. In età moderna Pascal, che ad Agostino si rifà, teorizzando l’importanza dell’esprit de finesse ha in mente una valorizzazione del singolare, che risulta peraltro appena abbozzata, e rimane parzialmente soffocata dal clima complessivamente dominante la sua riflessione: il mondo materiale per lui è opaco alla Trascendenza, e il miracolo, pur essendo evento appartenente al mondo, è come un intruso, un raggio di luce strana in una oscurità fitta, un filo estraneo in un labirinto per lo più percepito come ostile e minaccioso. Analoghi rilievi si potrebbero fare per Kierkegaard, autore pure intriso di spirito cristiano, e in cui si trova una valutazione, indubbiamente forte, della singolarità, ma talmente contrapposta alla banalità dell’universale da risultare appunto meno credibile di quanto meriterebbe: non si evince quanto lo di dovrebbe, che il singolare, su cui occorre fondare la propria vita, sia qualcosa di pienamente ragionevole, in quanto recante in sé il senso della totalità universale, con cui è in continuità/discontinuità. Predomina la discontinuità, e dunque il salto; dunque il singolare concreto è più l’occasione di un lavoro interno all’io, che una realtà capace di sprigionare una bellezza, oggettivamente significativa dell’Altro.
[34] Si potrebbe forse obiettare che anche la bellezza di un paesaggio naturale può costituire in qualche modo il referente di una certezza calda. In realtà ci sembra che si possa piuttosto dire che un singolare infraumano offre del materiale per alimentare una certezza calda, il cui fondamento è essenzialmente già dato in un ambito umano; ed è nella misura in cui il soggetto che contempla la bellezza naturale può fare appello a dei rapporti intersoggettivi che l’esperienza della bellezza naturale potrà essere per lui significativa, e fonte di una autentica certezza.
[35] La definizione di Buber come filosofo non è tranquillamente condivisa. Lo stesso Gadamer, che pure gli riconosce molto, nega che egli possa definirsi, propriamente parlando, un pensatore rigoroso: “La modalità però in cui Buber si è espresso era per così dire di tipo letterario, legata alla letteratura. Egli non era un pensatore accademico, era piuttosto un grande scrittore: certamente aveva anche una tempra di pensatore, ma soprattutto sulla base della tradizione chassidica che aveva rinnovato come poeta.”
A noi sembra che sia comunque possibile riconoscere a Buber un ruolo di notevole importanza, se non per il rigore dimostrativo, certamente per i contenuti che ha contribuito a focalizzare. Potremmo del resto osservare ad esempio che anche in Wittgenstein la dimensione assertiva (per quanto sistematica) prevale di gran lunga su quella dimostrativa, senza che perciò nessuno gli contesti il titolo di filosofo. Egualmente si potrebbe dire di Nietzsche.
[36] Pensiamo a Platone, la cui stima per la componente dialogica del filosofare è nota, e il cui pensiero al riguardo potrebbe essere sintetizzato dalla famosa frase “la verità è opera di uomini che vivono insieme e discutono con benevolenza”
[37] Cfr. Martin Buber: “l'uomo diventa io a contatto con il tu”, IUD, p. 79. Ma, come abbiamo già notato, è anzitutto un dato fenomenologico che non ogni tu può aiutare: non ogni rapporto ci restituisce a noi stessi e ci fa crescere. Atteniamoci per il momento ad una descrizione del fenomeno: non si tratta di dare dei giudizi di valore su persone. E nemmeno si tratta di dividere gli esseri umani in categorie definitivamente cristallizzate: chiunque può acquisire o perdere la capacità di essere di richiamo alla verità.
[38] “Quando tu mi guardavi/ lor grazia in me imprimevan gli occhi tuoi: /per questo tu mi amavi / e in questo meritavan / li miei mirar ciò che in Te vedevano. /Non voler disprezzarmi: / se bruno di colore mi hai trovato / ben puoi ora guardarmi / dappoi che mi hai guardato / ché grazia in me e bellezza hai suscitato”, Cantico spirituale, strofa 32 e 33 (cfr. Opere complete, Roma 1975, p.502). Come saprà il lettore che abbia una certa familiarità col dottore carmelitano (o con testo biblico) il mistico di Fontiveros si ispira al Cantico dei Cantici: anche la Sulamita vi riconosce di essere "bruna" (1,5). Ma nel Cantico veterotestamentario non viene posta alcuna relazione tra lo sguardo dello Sposo e la trasformazione della sposa.
[39] Come esprime mirabilmente il quale di Rembrandt, Il figliol prodigo. Si veda anche l’insegnamento di Giovanni Paolo II nella Dives in misericordia, circa il rapporto del padre verso il figliol prodigo
[40] Si tratta di un tema più volte affrontato dalla filosofia francese del Novecento, da Sartre a Marcel.
[41] «L'altro io posso oggettivizzarlo a condizione che lui stesso per primo si oggettivizzi.» (S.Grygiel, “Profanazione, ovvero contemplazione e sacramento”, tr. it. in L'uomo visto dalla Vistola, Cseo, Bologna 1978, pp.17/52 [Gryg], p.21.
Altre osservazioni interessanti su questo tema sono state in effetti svolte dal citato filosofo polacco Stanylaw Grygiel, allorché egli distingue (nel solco di Martin Buber), due modalità fondamentali di impostare il rapporto con gli altri: una oggettivante (quella che Buber avrebbe chiamato la modalità costitutiva del “mondo dell’esso”), che si ferma al pro-fanum (nel senso di davanti e fuori (pro) dal tempio sacro (fanum) della soggettività, che viene perciò pro-fanata), agli aspetti concettualmente controllabili (e in qualche modo praticamente dominabili) dell’altro, misconoscendone la profondità inoggettivabile, il centro in qualche modo sacro della soggettività; l’altra (quella che Buber avrebbe chiamato la modalità costitutiva del “mondo del tu”) riconosce invece l’altro come soggetto, e permette così un vero incontro, un incontro non pro-fano, ma in fano (Cfr. Gryg, pp. 29/35.). Grygiel distingue in effetti un duplice livello del soggetto umano, in relazione all’alterità personale: un livello oggettivabile, e uno inoggettivabile, ovvero, quella che potremmo chiamare una "periferia" (una esteriorità osservabile) e un “centro”, che Grygiel chiama anche, riprendendo, come lui stesso dice, il linguaggio dei mistici, “Rocca interiore”, “Montagna inaccessibile” o “Abisso dell'anima”, nel quale l'uomo “è se stesso”, e che non è raggiungibile da altri esseri umani se il soggetto stesso non lo voglia.
[42] È forse opportuno precisare ulteriormente che cosa significhi questa epifanicità della corporeità, questa per così dire pneumatofanicità del somatico. Intendiamo dire che quanto di volontario si produce nella dimensione corporea, che è quella che si offre alla conoscenza sensibile degli altri soggetti, rispecchia la verità del soggetto che si esprime (nel senso prima precisato). E il fattore volontario della manifestazione corporea consiste nelle parole, nei gesti, nelle azioni, nell’espressione del volto, nell’atteggiamento, in tutto ciò insomma che costituisce per gli altri soggetto segno visibile, in questo senso “oggettivo”, del centro spirituale (e in quanto tale non visibile) del soggetto esprimentesi.
[43] Questo fattore lo possiamo esprimere dicendo che potrei anche essere di fronte all’affiorare più luminoso della verità totale in un concreto umano, ma se non decidessi personalmente, liberamente di riconoscere e accettare questo svelarsi di una presenza che abita nelle altrui soggettività (così come preme e bussa dentro di me), potrei restare cieco e sordo, potrei non esserne più di tanto scalfito, e continuare a lamentare l’assenza di un significato esauriente del reale.
[44] Noi riteniamo anzi che una prova dell’esistenza di Dio si possa dare, facendo leva sulla sola razionalità contemplante, benché essa resti a livello di quella che abbiamo proposto di chiamare certezza fredda.
45 In un senso almeno logico.
🛒 ricerche / acquisti
cerca libri su Amazon sul tema: verità certezza tomismo Blondel certezza calda certezza fredda filosofia teologia università cultura libri on-line Verità e certezza: .